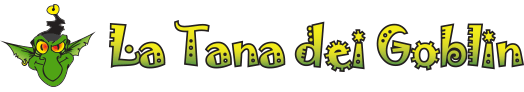Ma stupendo!
Questa serie è composta da tre articoli
1 - Il Pastorale nel GdT
2 - Soft e Hard Pastoral (18/04/2025)
3 - Hard Pastoral (25/04/2025)
“I primi raggi dell’alba filtrano nel pulviscolo a mezz’aria della camera di Thomas. Una fioca luce attraversa il legno di quercia della finestra, svegliando l’anziano contadino. A passi stanchi, Thomas si avvia giù dalle scale, i suoi pensieri già indirizzati a elencare i doveri della giornata. A metà scalinata lo raggiunge un profumo familiare di uova in padella e salsiccia. La colazione è già ordinatamente preparata sul tavolo della cucina. Il fumo proietta astratte figure nel riflesso del sole del mattino. Mentre gusta l’abbondante colazione, i suoi attrezzi lo osservano dalla porta semiaperta del magazzino: fedeli compagni di lavoro, che come lui negli anni hanno accumulato esperienza, rughe, e qualche acciacco. Alzandosi dal tavolo, Thomas già immagina il crepitio del terreno sotto i suoi stivali, mentre la morbida melodia della lama dell'aratro penetra la fertile terra al ritmo lento ma costante degli zoccoli dei buoi.”
Che immagine calorosa, vero? Nessuno storcerebbe il naso qualora dovesse apparire nella descrizione introduttiva di una nuova edizione di Agricola, o di un qualsiasi altro gioco dal tema simile. Ma a cosa si riferiscono davvero quelle immagini così evocative? A quale bisogno risponde?

Permettetemi una premessa metodologica. Il lettore mi perdonerà la quasi totale assenza di riferimenti diretti a titoli specifici in questo primo articolo. Tuttavia, credo che sia ormai difficile negare che il gioco da tavolo stia raggiungendo un livello di complessità estetica, sociologica, e antropologica per cui valga la pena espandere i temi ricorrenti del nostro hobby preferito e inserirli in un contesto culturale molto più ampio. In altre parole, soprattutto nell’ultimo quarto di secolo, il gioco da tavolo ha smesso di parlare solo a se stesso (come gioco), e ha iniziato un dialogo di più ampio respiro con il mondo. Per come la vedo io, è arrivato il momento di dare spazio a quel dialogo, e questo articolo (il mio primo intervento sulla Tana) vuole essere un piccolo, iniziale contributo per collocare il gioco da tavolo, i suoi temi, i suoi autori e i suoi giocatori nel fitto reticolo di storie interconnesse di cui la storia del mondo è composta.
Non temete: i riferimenti a specifici giochi e autori arriveranno in gran quantità, ma per evitare di scrivere un unico articolo da ottomila parole, ho pensato fosse più saggio e di più facile fruizione dividerlo in una trilogia.

Ma cosa si intende quando si parla di pastorale? Con il termine pastorale solitamente ci si riferisce a correnti poetiche e letterarie il cui fulcro tematico è concentrato su una “idealizzazione della vita dei pastori e in genere della vita campestre” (definizione Treccani). Datare un’origine precisa del genere è impresa storiograficamente impossibile (e probabilmente anche poco sensata), dal momento che una certa forma di idealizzazione di quella vita esiste sostanzialmente sin dalle prime albe del genere umano, quando i primi insediamenti nascono proprio come agglomerati comunitari riuniti intorno alle coltivazioni, e molto del mondo magico pre-religioso e il suo simbolismo è intriso di rituali propiziatori al raccolto, o che si riferiscono metaforicamente ad esso. Il termine pastorale, a dire il vero, è un termine ben più moderno, derivato dal latino, e strettamente connesso alla tradizione cristiano-cattolica. Prima di esso, la poesia e letteratura greco-latina di Teocrito e Virgilio forgia il termine bucolico, la cui etimologia è un concentrato di tutti i temi evocati nel genere (boukolos, bous). Da qui si apre poi uno spettro ancora più ampio di termini legati a questo mondo idealizzato: idillico, campestre, arcadico, rurale, agreste, georgico, e appunto, pastorale. Ognuno di questi termini contiene diverse sfumature ed è legato a diverse tradizioni letterarie. Facendo un salto nel tempo fino ai giorni nostri, a cosa possiamo ricondurre questa presenza massiccia del genere nel nostro presente? A mio avviso, per poter posizionare questa tendenza dobbiamo dapprima tracciare alcune potenziali cause. In primis, l’esplosione dell’industrializzazione nel mondo occidentale. Poi, quel generalizzato sentimento malinconico che prende il nome di fin de siecle e le due guerre mondiali, e infine la secolare questione della nostalgia.

Nel picco di questo periodo storico, alla fine del XIX secolo, un generalizzato senso di malessere assale la società europea e americana, soprattutto nel ceto medio e borghese, al punto da meritarsi un termine preciso: fin de siecle. Poca fiducia nel futuro, un sentimento di “fine imminente”, e una stanchezza per la vita moderna hanno portato scrittori e artisti a cercare vie di fuga, lontane dalla società urbana. Lo scrittore tedesco Thomas Mann, più di ogni altro, volge il suo sguardo verso questo sentimento generalizzato. Nel suo La montagna incantata ci racconta in parte proprio questo: una fuga fuori dal tempo, dentro un sanatorio in mezzo alle montagne svizzere, nel disperato tentativo di combattere l'incurabile malattia dell’uomo moderno.
Questa lunga premessa storica mi serve ora per introdurre la mia definizione di nostalgia. Nostalgia, nella sua definizione più storica, è identificabile come un sentimento di malinconia legato alla lontananza da casa (qualunque essa sia o qualunque forma essa prenda). Dal mio punto di vista, però, in questa descrizione manca un tassello fondamentale: la nostalgia è infatti frutto di una illusione. Quel luogo, quell’oggetto lontano che tanto ci manca, a cui pensiamo prima di andare a dormire e che ci fa stare bene, non esiste. È un costrutto generato dalla fallibilità della nostra memoria. Come pietre esposte alla lenta erosione dei venti e delle piogge, i nostri ricordi con il tempo perdono i tratti più appuntiti, e si trasformano in una collezione di ciottoli di fiume, perfettamente lucidi e levigati. Un museo di ricordi artificiali da cui attingiamo ogni qualvolta sentiamo il desiderio di percepire lo sfrigolio del calore di un camino sulle nostre mani. In questo senso, il mondo pastorale agisce un po’ come un silo di ricordi comuni per una larga comunità di persone, tutte culturalmente e inconsciamente legate a quell’ideale inesistente.
La questione però (chi l’avrebbe mai detto…) è più complessa e meno lineare di quanto appaia in questo primo articolo. Nei prossimi articoli approfondiremo le diverse declinazioni che il mondo pastorale ha preso soprattutto nel secolo scorso e nel nostro, riassunte nei concetti di soft pastoral e hard pastoral, e vedremo dove si collocano in questo scenario numerosi giochi, e quali collegamenti si possono fare con musica e letteratura.
Giunto al termine di questo sproloquio, il lettore-giocatore potrebbe (giustamente) chiedersi: “E quindi?”. Per questa ragione, mi piacerebbe lasciare in coda a questo articolo una proposta pratica per applicare questa riflessione al nostro approccio quotidiano al gioco da tavolo. La prossima volta che vi troverete davanti ad una partita a Clans of Caledonia o Agricola, e proverete quel piccolo brivido di comfort davanti alle confortevoli illustrazioni e ai temi familiari, trattenete quel sentimento di piacere e provate a tracciarne le origini. Quali ricordi vengono attivati? Quali memorie rievoca? Soprattutto per coloro (e credo siano la maggioranza, me compreso) che non hanno mai vissuto una vita contadina, dove potrebbero collocarsi le origini di quella fascinazione? Camminare con consapevolezza dentro la nostra Arcadia può essere pericoloso, può rivelare piacevoli ricordi impolverati così come inaspettate disillusioni. Eppure, trovo straordinario che, solo grazie ad un gioco, si possa intraprendere un viaggio così profondo con noi stessi, che vada al di là del giocare una carta o piazzare un lavoratore.
Germanista di formazione, americanista nelle notti d’inverno quando nessuno può spiare dalla finestra.
Ho iniziato con anni di serate davanti a Risiko e tentativi falliti di proporre titoli più esuberanti come Munchkin o Age of Empires III. Ho (ri)scoperto il gioco da tavolo moderno nel 2020, e mai più abbandonato. Tra i miei titoli preferiti spiccano Sulle tracce di Marco Polo, Scythe, Terra Mystica, La Festa per Odino, Darwin’s Journey e Gloomhaven.
Nel tempo libero mi guadagno da vivere negli Stati Uniti come musicologo, compositore e pianista.